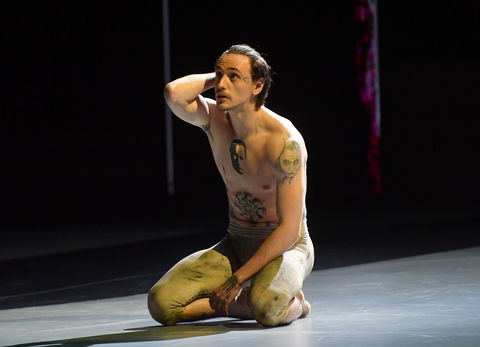L’eutanasia secondo la Treccani
di Chiara Lalli
Pubblicato il 2014-12-11
La voce dell’enciclopedia on line è imprecisa e ambigua

Non è la prima volta che rimango perplessa ma la voce «eutanasia» supera di molto la perplessità. Vediamo i passaggi più bizzarri.
L’uccisione medicalizzata di una persona senza il suo consenso, infatti, non va definita eutanasia, ma omicidio tout court, come nel caso di soggetti che non esprimono la propria volontà, la esprimono in senso contrario o non sono in grado di manifestarla: neonati, feti, embrioni, dementi, malati gravi privi di coscienza.
Quindi anche l’aborto è omicidio tout court (feti, embrioni)? Benissimo.
Non rientrano inoltre nel concetto di eutanasia l’astensione o la sospensione di trattamenti futili e di forme di accanimento terapeutico, nonché la sedazione terminale (uso di farmaci sedativi per dare sollievo a sofferenze insopportabili negli ultimi momenti di vita). Non va confusa poi con l’eutanasia la rinuncia all’accanimento terapeutico, ossia a quegli interventi sproporzionati, gravosi e inutili rispetto alla possibilità di arrestare il processo della morte del paziente, nel tentativo di prolungare la vita a ogni costo. Esiste un consenso pressoché unanime circa l’illiceità etica, deontologica e giuridica di questa pratica, che proprio in quanto consistente in un’insistenza sproporzionata e futile rispetto al raggiungimento di ogni obiettivo, non si può definire una pratica terapeutica. La rinuncia all’accanimento, tuttavia, non legittima la sospensione delle cure ordinarie necessarie a un accompagnamento dignitoso del morente. Tra queste si discute se vadano incluse l’idratazione e l’alimentazione artificiale, quando non risultino gravose per il malato o l’organismo non sia più in grado di recepirle.
Qui entriamo in un terreno minato. Bendati e senza manco una mappa approssimativa. L’espressione «accanimento terapeutico» dovremmo abbandonarla per sempre perché è ambigua e inutile. I due aspetti da considerare sono: quello clinico (futile o no) e quello della volontà (è bene ricordare che possiamo rifiutare qualsiasi trattamento, non solo quelli futili, ma pure quelli utilissimi, efficaci e con pochi effetti collaterali). Quindi nemmeno la rinuncia a interventi proporzionati è «eutanasia». Il consenso unanime non è molto interessante. La legge protegge questa libertà – per fortuna. La «sospensione delle cure necessarie» è dunque possibile. Mai sentito parlare di autodeterminazione? Quanto alla «idratazione e alimentazione artificiale» (la parola corretta è nutrizione) non c’è alcuna discussione al riguardo – come non c’è per alcun trattamento medico. Non c’è discussione sulla possibilità di «rinunciarvi». Il passaggio dal paternalismo all’autodeterminazione sanitaria sta proprio qui: che io posso decidere se e come curarmi.
Diversa è l’eutanasia come abbandono terapeutico, ossia la sospensione di qualsiasi trattamento nell’intento di anticipare la morte: in questi casi, infatti, non è la condizione patologica a far morire, ma l’omissione di sostentamenti ordinari. Va, pertanto, considerata una forma di eutanasia passiva.
In questo passaggio c’è la medesima nebbia dell’inizio: identificare la cosiddetta eutanasia passiva con la sospensione generica è troppo vago. Inoltre anche la differenza passiva/attiva dovrebbe avere il ruolo che merita: ovvero quello di una distinzione psicologica più che morale (vedi James Rachels). Giuridicamente esiste una distinzione tra azione e omissione, ma nel caso della sospensione dei trattamenti torniamo sempre alla libertà di decidere. Posso decidere se cominciare una chemioterapia o no pur sapendo che se declino morirò entro qualche mese. Questa anche è forse eutanasia passiva? Le definizioni ci servono a fare ordine: quando i confini semantici diventano tanto nebbiosi e approssimativi non servono a niente. Se non a confondere le idee. O a provare che chi ha redatto questa voce ne ha più nebbiose di voi.
Un aspetto delicato riguarda il rifiuto delle terapie (o dissenso informato) da parte di un soggetto capace di intendere e di volere. In proposito, la dottrina dominante ritiene che la rilevanza giuridica riconoscibile all’autodeterminazione del paziente incontri un preciso limite nel principio del rispetto della persona umana. La libertà di determinazione del soggetto in relazione alla propria salute (artt. 3-13-32 Cost.), infatti, appare meritevole di riconoscimento fintanto che non sia volta alla soppressione di sé o alla eliminazione di componenti essenziali della personalità. Ciò si traduce nell’impossibilità per il soggetto di disporre della propria esistenza con forme di suicidio assistito e di eutanasia volontaria.
Nessuna delicatezza, ma un diritto che è molto facile capire. Se sono in grado di intendere e di volere decido io e nessun altro. Qualsiasi sia la terapia di cui stiamo parlando. Il rispetto – come la dignità – sono concetti troppo vaghi per costituire una indicazione normativa. Ognuno considera rispettosa e dignitosa una certa scelta (ognuno dovrebbe poter decidere in base alle proprie preferenze). E la difesa del rispetto non può essere invocato per giustificare alcun trattamento sanitario (gli esempi classici al riguardo sono le trasfusioni per i testimoni di Geova: per noi «ordinari» mezzi di sopravvivenza, per i TdG inammissibili – se il testimone di Geova è adulto e le sue capacità cognitive non sono compromesse al punto da mettere in dubbio la possibilità di compiere scelte e di comprenderne le conseguenze, nessuno dovrebbe permettersi di andare a dirgli come vivere e cosa accettare o rifiutare).
Le cure palliative, in tal senso, danno sollievo; sostengono la vita e guardano al morire come a un processo naturale; non intendono né affrettare né posporre la morte; integrano aspetti psicologici e spirituali nell’assistenza al paziente; utilizzano un approccio di équipe per rispondere ai bisogni del paziente e della famiglia, e possono influenzare positivamente il decorso della malattia (OMS, 2002). Dal punto di vista giuridico, nell’ordinamento italiano l’eutanasia attiva è assimilabile all’omicidio, l’eutanasia passiva è identificabile nell’astensione a praticare terapie nel rispetto delle norme di legge. Il codice penale non prevede un’apposita disciplina per l’omicidio per eutanasia, trovando, invece, applicazione, di volta in volta, le disposizioni inerenti l’omicidio volontario (art. 575) o l’omicidio del consenziente (art. 579). L’applicazione di quest’ultima norma non è sempre possibile, perché spesso il consenso prestato è invalido a causa delle menomazioni psichiche che possono accompagnare la patologia in corso. In tali casi si fa riferimento alla disciplina prevista per l’omicidio comune che, a seconda delle fattispecie concrete, può essere attenuata (motivi di particolare valore morale o sociale) o aggravata (premeditazione o rapporti di parentela). È considerato reato anche l’istigazione o l’aiuto al suicidio ex art. 580 c.p. L’eutanasia passiva è ammessa solo in ambito ospedaliero nel caso di morte celebrale, previo consenso dei parenti; sono inoltre necessari il permesso scritto del primario, del medico curante e del medico legale. In caso di disaccordo si adisce il giudice competente.
La fine è notevolissima: l’eutanasia passiva sarebbe ammessa solo in ospedale e in caso di morte cerebrale. Ovvero, quando siamo già morti. E con il consenso dei parenti?! No, davvero. La confusione tra i criteri per accertare e certificare la morte cerebrale, le definizioni, i parenti, i primari e il Bignami di diritto degli anni ’50 è così profonda che sembra difficile bonificarla (e la sciatteria rispetto alle cure palliative sembra perdonabile). La morte cerebrale è da tempo il criterio (giuridico e filosofico) di morte. Qualcuno dichiarato morto cerebralmente è morto – per usare un’espressione dell’estensore di questa voce bizzarra – tout court. A meno che non siate sostenitori della «Lega Nazionale Contro la Predazione di Organi e la Morte a Cuore Battente» (sic).